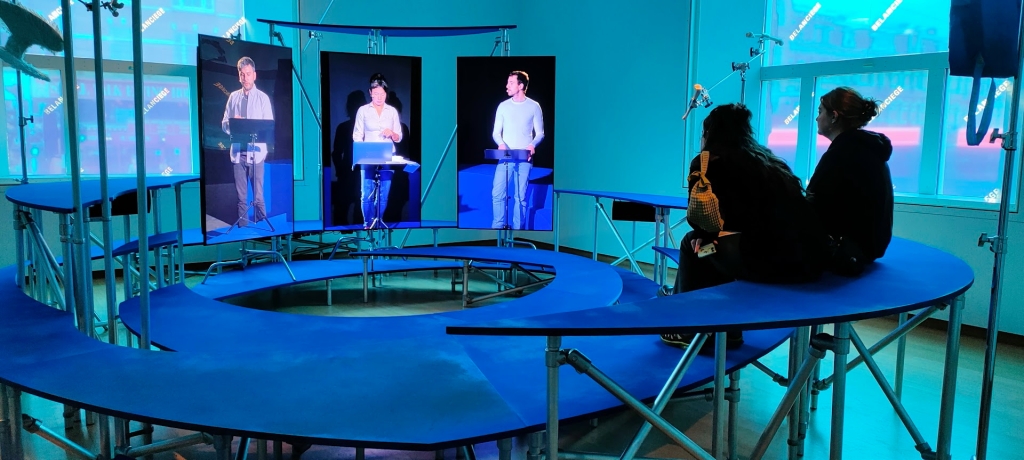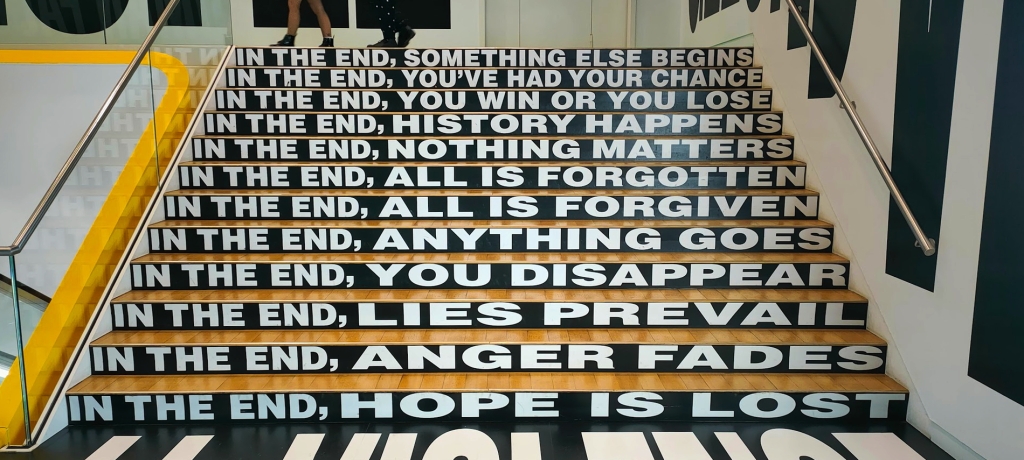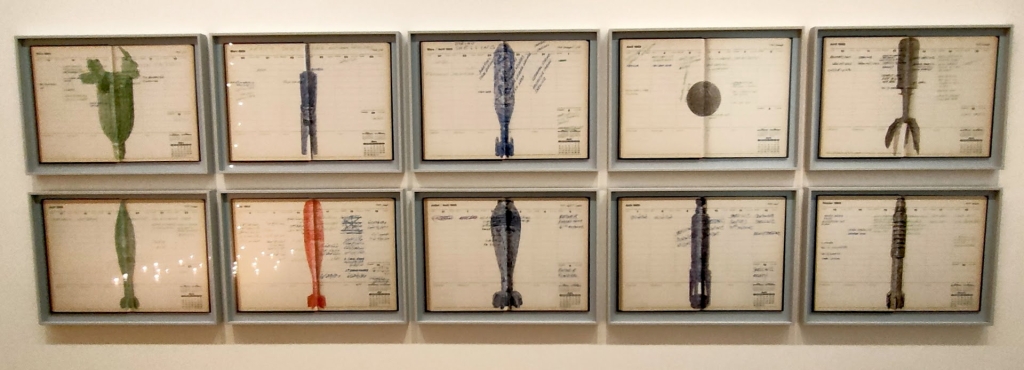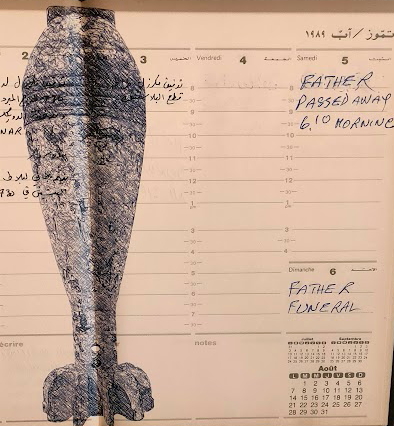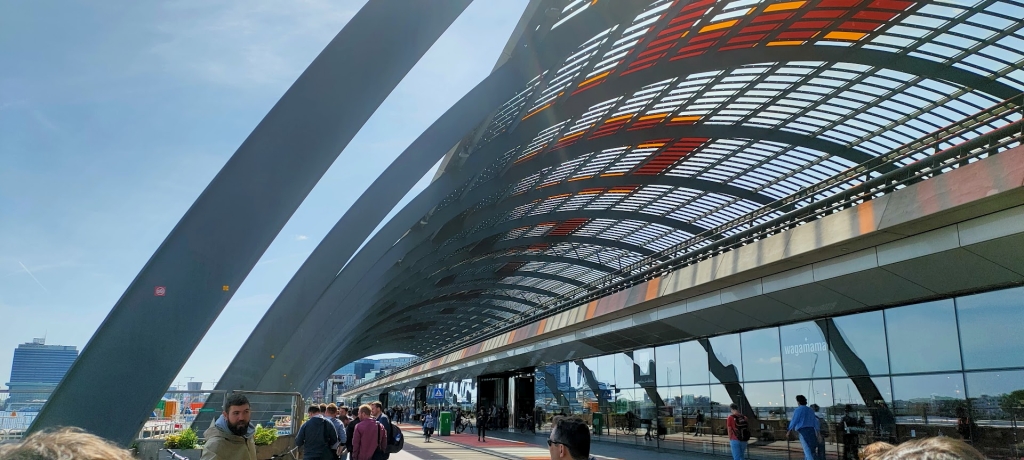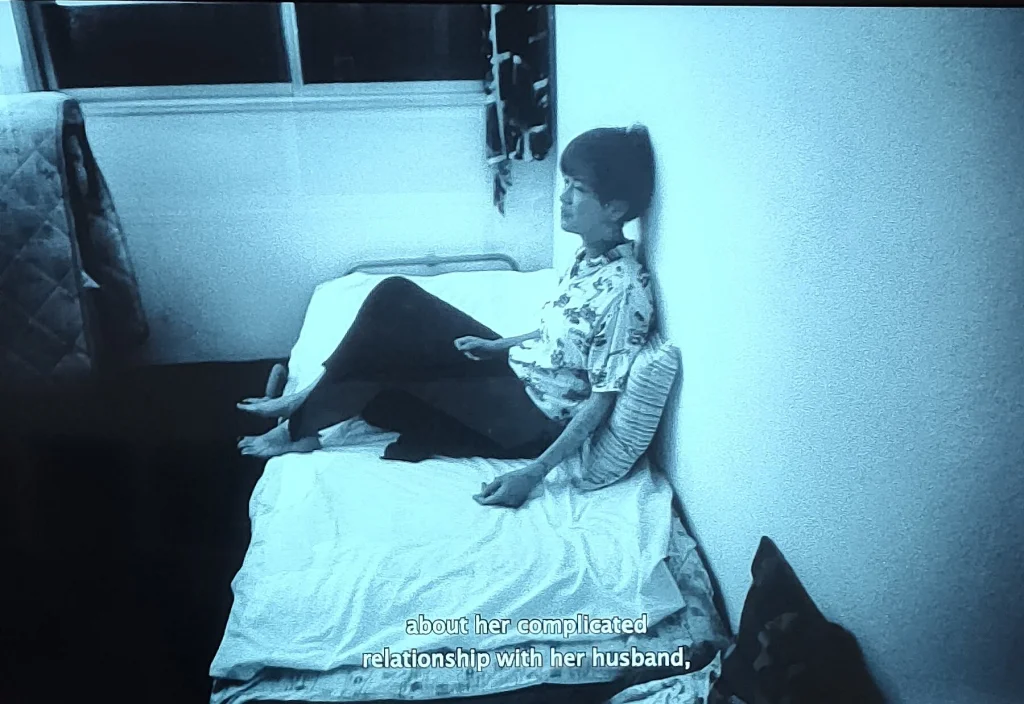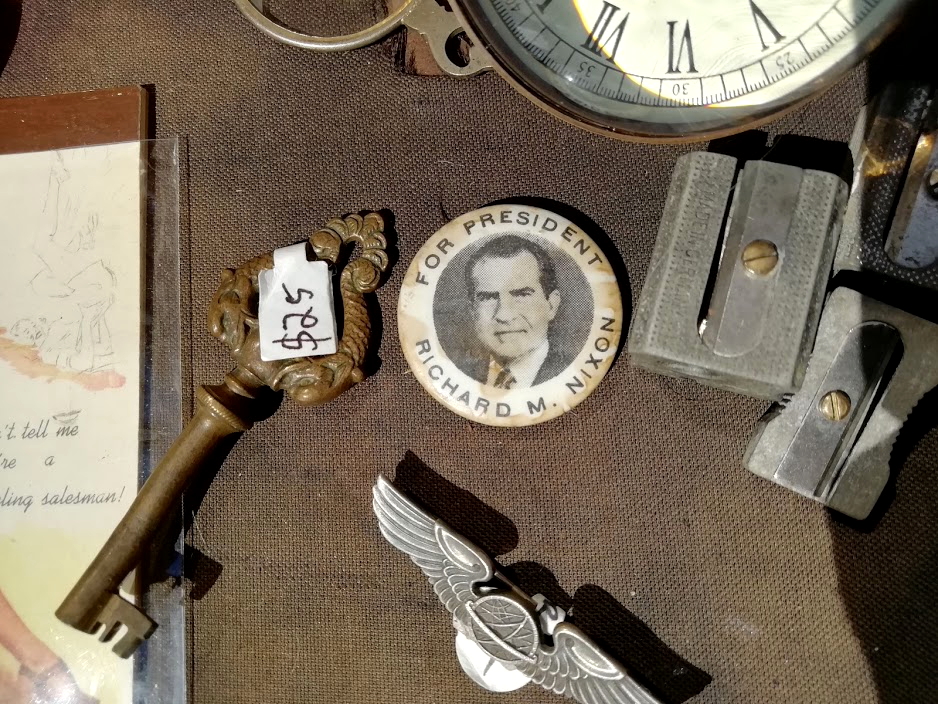Tags
degustazioni, donne, incontri, pensieri, persone, spostamenti, uomini, vino
1.
Ci metto un po’. A tirare fuori tutto subito c’è il rischio di lasciarsi condizionare dall’entusiasmo, sopraffatti da emozioni e sentimenti e impiastricciati di melassa. Serve tempo. Fermarsi, riflettere, scrivere. Scrivere è il modo migliore per mettere in fila [in ordine] i pensieri.
Con la fotografia funziona più o meno allo stesso modo, il risultato non è immediato come può sembrare a qualcuno.
Scatto molte foto, molti ritratti, anche riuscendo a essere molesto. In passato usavo una reflex, ora sono passato al telefono. Una macchina fotografica dà maggiore soddisfazione ed è più precisa, ma va usata quotidianamente. Perdere la mano è facile, riacquistarla è un’impresa. Dopo circa un anno di pausa, le foto mi vengono sghembe, sovraesposte oppure buie, male inquadrate. Il telefono ha il duplice vantaggio di pesare e ingombrare meno rispetto a una reflex. Ha una minore definizione, dà minore autonomia nelle scelte, lenti e obiettivo sono fissi. Però è sempre a portata di mano e, sopratutto, è veloce, consente di scattare rapidamente quando vedo qualcosa che mi interessa. Quale che sia il mezzo, può succedere che io mi senta preda di un impulso, di uno stimolo indefinibile e sotterraneo. In automatico, senza pensare, inquadro e premo il pulsante. Vedo il soggetto che voglio riprendere e seguo lo stimolo, senza riuscire a definirlo. Quando riguardo la foto trovo elementi di cui non mi ero accorto scattando. Un dettaglio, una espressione, una postura. Una composizione, anche, che non avevo cercato consciamente e che invece, ora lo vedo, è funzionale alla rappresentazione di quello che sentivo al momento di scattare. Possibile che questi siano aspetti comprensibili solo a me. Oppure che io mi sia immaginato tutto.
Per viaggiare l’auto è il mezzo di trasporto migliore [se non ci sono oceani di mezzo. Ma per quelli ci vuole il cosobianco e, insomma, sapete come la penso]. Parto quando voglio partire, accelero, rallento, mi fermo, riparto, ascolto musica, canto. E guardo. Se posso evito le autostrade, monotone e infinite distese di asfalto. Sono poche quelle in cui ci sia qualcosa che valga la pena guardare. Quella che da Ivrea porta in Valle d’Aosta e fino al Monte Bianco e quindi in Francia è una di queste.
2.
Se fossi nato in Borgogna sarei morto da un pezzo. Non per il vino, non sono un bevitore ingordo. Non lo sono più da anni. E il vino qui [lì] è pure mediamente meno alcolico che altrove nonché molto più digeribile rispetto alla media dei vini che bevo abitualmente. Non essendo capace a sputare [mi sbrodolo e non è un bello spettacolo], l’alternativa durante gli assaggi è tra versare nella sputacchiera quanto resta nel calice o buttarlo giù. In Borgogna ho buttato giù praticamente tutto senza un accenno né di mal di testa né di mal di stomaco, senza mezzo fastidio intestinale. Il problema di sopravvivenza si pone quindi non con il vino, ma con lo jambon persillé, con l’époisses, con il comté, con la charcuterie, che da queste parti è epidemica. In Borgogna si mangia male? Terra di grassi animali e aglio e io non so resistere né agli uni né all’altro.

Il pane francese è eccellente. La competizione tra cibi italiani e francesi è una minchiata, le classifiche lo sono sempre, impossibile essere oggettivi. Sui formaggi, ad esempio: qui c’è il parmigiano reggiano, lì c’è il beaufort. Posso rinunciare a uno dei due? Sono scuole di pensiero diverse, la nostra e la loro. Su burro e pane invece non ho dubbi. Le nostre panetterie sono diventate luoghi di spaccio di pani mediocri quando non pessimi. Invece in Francia anche il pane dozzinale è migliore di quello italiano. Abbiamo dimenticato che, come diceva mia nonna, il pane è la base.

Nei bar à vins si mangia piuttosto male, sono rari i piatti caldi. Quand’anche i formaggi e i salumi serviti siano di qualità, non si può mangiare solo questi. E l’alternativa ai soliti taglieri invece che da verdure è spesso rappresentata da scatolette e vasetti: acciughe sotto olio, terrine variobestie preconfezionate, creme di pesce frullato spalmabili e alquanto puzzolenti. In compenso le carte dei vini sono incredibili. Se non andate da Maison du Colombier, portatevi un panino pomodoro e mozzarella da casa.

Poi però a Gevrey-Chambertin c’è Jeannette.

Il Resto Jeannette, gestito dall’omonima mitologica e dalla sua cagnetta Thelma, è un bistrot/bazar dove si può mangiare un piatto caldo fatto come a casa. Ad esempio un boeuf bourguignon. Arredamento che sa di anni ‘60 e anni ‘70, pieno di colore e calore e oggetti e foto incollate alle pareti in un felicissimo caos.




E ci sono ristoranti veri e propri che valgono la pena. A Meursault gran cena, l’ultima sera prima del ritorno, da Au Fil du Clos, chef Jean-Christophe Moutet.

Godurioso Piccione di Bresse con spugnole, carta dei vini profonda e il primo Coche-Dury della mia vita. Un rosso, Volnay 1er cru. Per darne un’idea prendo a prestito la definizione che Marco Ciriello, uno dei grandi scrittori viventi in lingua italiana, aveva dato di un regista del cinematografo: rigoroso senza essere elitario. [Il vino. Perché il prezzo, la verità, un poco elitario è].

Quindi ha senso dire che in Borgogna si mangia male? No.
Un problema di alimentazione poco salutare c’è, ma chissene. Più dei sapori contano i ricordi. Le cene migliori, quelle che non si dimenticano, dipendono da chi è con noi al tavolo. E dai gesti inattesi.
“La tavola è conviviale, la cucina è circadiana”
P.L.
La Borgogna è per me anche la terra di un’occasione perduta. Sono lento e arrivo sempre tardi, su tutto: ai tempi della pallacanèster non a caso mi chiamavano Bronto. Il fatto è che quando era possibile farlo decisi di non mettere da parte vini borgognoni e oggi comperarli è diventato impegnativo ove non impossibile. Alla stupidità mia aggiungo un poco di sfiga: tolte pochissime eccezioni piuttosto indimenticabili, la maggior parte delle bottiglie comprate a caso furono deludenti. Per spremiture di legni, mancanza di frutto, brett, rusticità, varie ed eventuali. Circolava anche la falsa credenza, diffusa da certi individui malsani, che i vini di Borgogna fossero quasi tutti anoressici scheletri di acidità. Vabbeh, la macchina del tempo non esiste, si guarda avanti, si fa quel che si può, per l’impossibile ci stiamo organizzando.
La morale della favola [della fava] è che come minimo non bisogna dare retta né al prossimo, né ai luoghi comuni. Come quello della cronica assenza di bidet negli alberghi francesi, assenza che, superando la soglia della camera assegnataci dal concierge, incombe come un temporale in arrivo mentre si è senza riparo. Uhm. A dirla giusta questo non è un luogo comune: è un fatto, i bidet non ci sono davvero.
Divago. In questi anni leggendo le cronache di appassionati bevitori entusiasti dei vini borgognoni, gente che venderebbe la madre a una popolazione nomade a caso del vasto Nord-Africa in cambio di una bottiglia di Clos de Tart [ma solo se di annata consona], sono stato colto dal leggerissimo sospetto di essermi messo in una prospettiva sbagliata. Nella mia ignoranza indotta mi chiedevo cosa trovassero costoro di tanto straordinario nel pinot noir. Non sarà, mi dicevo, una moda? Sulla Borgogna ho letto molto. Ma. Finché non si sperimenta qualcosa di persona, e vale per il vino come per tutto [ostriche, parapendio, bdsm, etc], non è possibile capire nulla, nel bene oppure nel male.
3.
La Borgogna è una sorpresa. Ci ero passato in mezzo anni fa, attraversandola per andare a nord. Ma era una giornata di cielo terso, non mi ero fermato che un paio d’ore per pranzo e qualche acquisto, e non avevo capito niente. Questa volta è andata diversamente perché ho avuto tempo. Adesso sto provando a capire cosa io abbia sentito di speciale. Quindi scrivo. Ci metto un po’, l’ho detto all’inizio.

Intanto c’è il cielo. Il cielo, così basso che non puoi evitare di pensare che da un momento all’altro potrebbe caderti sulla testa. Eppure non fa paura. Lo vedo bene, questo cielo, anche grazie alla coltre di nuvole invernali, anch’esse basse, e scure e cariche di pioggia, che lo sostengono, trattenendolo dal venire giù. Le nuvole fanno da tetto, filtrano la luce di un sole nascosto e la restituiscono a terra, cambiata e cangiante. Forniscono la consapevolezza, la certezza, la misura di questo cielo. Per un fotografo è come stare in uno sconfinato studio fotografico naturale, al chiuso essendo all’aperto. Tutto si gioca nel rapporto tra le nuvole/tetto e la terra/pavimento. È la forma della campagna, con il cielo che sembra rispondere alla terra, semipianeggiante per la gran parte. Bassa.

Basse anche le viti, in vigneti con impianti fitti, con i cavalli che passano tra filari stretti, impraticabili per i trattori, e potatori impegnati a bruciare i sarmenti in vigna, come previsto da tradizione e legge. Mai visto viti così basse, mai visto cielo così basso. Tutto sembra a portata di mano. Là dietro, sullo sfondo, ci sono anche le montagne, è vero, e sarebbero in realtà colline, come la montagna di Corton [il “panettone”] che emerge dalla pianura. Eppure tutto sembra compresso, dall’alto in basso, lasciato scivolare sul fondo, allungato, disteso. È una compressione che non fa mancare il respiro. Non opprime. Infonde invece un senso di protezione. Protezione dal mondo esterno. Come se là fuori ci fossero i leoni o gli animali sinistri. Protezione da sé stessi. Quando i leoni sono dentro di noi. I colori fanno la loro parte, e i grigi, gli azzurri, i verdi sono la migliore combinazione cromatica possibile per richiedere, e ottenere, pace.



4.
Il viaggio è stato veloce. Cinque o sei ore volano se ci sono musica buona e chiacchiere. All’arrivo l’albergo è più bello del previsto. È pulito [sembra ovvio, non lo è], la camera è spaziosa, arredata con gusto, il letto è comodo, i dintorni sono silenziosi e siamo a dieci minuti a piedi dal centro. I gerenti, termine che traduco alla lettera non sapendo dire che corrispettivo abbia in italiano [né voglio controllare] e che mi piace molto, hanno una gentilezza sorridente e laterale, discreta.
La cosa che mi colpisce degli alberghi francesi è il bagno. Non per il bidet, di quello ho detto prima. Il bagno è composto da due locali. In uno ci sono lavabo e doccia, nel secondo c’è la tazza di ceramica bianca, quella che quotidianamente imbrattiamo della nostra essenza [la rothiana macchia umana è un’altra cosa]: uno stanzino stretto, senza finestre, quasi punitivo. Se si è in due questa soluzione abitativa può essere comoda perché si possono usare contemporaneamente i due locali. Invece a me viene da pensare che in Francia il senso sia diverso: dove ci si lava non si caga. E viceversa. Forse è questo il motivo per il quale in nessuno dei due locali c’è un bidet: per non creare confusione. [Non è vero, il motivo è un altro].
Gli indigeni, ad eccezione di un certo commesso di gastronomia, sembrano simpatici. Può pure essere che in realtà non lo siano, non ne ho incontrati che pochi e per poco tempo. Però tutti erano gentili, sorridenti. [Salutavano sempre]. Lo stereotipo del francese lo vuole stronzo ma so che lo stronzismo non ha nazionalità. Nel nord o anche nel Perigord, per esempio, ho trovato gente affabile e cortese. Gli stronzi più che altro li ho visti a Parigi e in Provenza.

5.
La lingua è un problema. Non avendo mai voluto studiare francese [va bene, avevate ragione], comincio a capirlo discretamente a partire dal terzo giorno di permanenza in loco. Qualche concetto, ahimè, è andato perduto, la sostanza spero di no.
Da qui in avanti qualche appunto sui vini. Poca roba, descrizioni buttate giù sul momento con qualche considerazione elaborata successivamente. Chi non avesse voglia di leggere ha tutta la mia comprensione.
DOMAINE DE L’ARLOT
Assaggiamo campioni dell’annata 2021 presi dalle botti, annata che come avremo modo di sperimentare, qui e altrove, ha dato vini più dinamici e meno concentrati rispetto alla 2020. Qualcuno ancora un po’ sbirulino, la verità.

Antico Domaine, è di proprietà di un gruppo assicurativo francese dalla fine degli anni ‘80. Hanno vigneti sia a Nuits Saint Georges che a Vosne Romanée. Nella degustazione, dopo essersi fatta brevemente aspettare, ci segue Geraldine Godot che è l’enologa del Domaine da quasi un decennio.

– CLOS DU CHAPEAU 2021, R.
Caratterizzato da una acidità vibrante e già ben indirizzata. Nitido il frutto.
– NUITS SAINT GEORGES CLOS DE L’ARLOT 1ER 2021, R.
Maggiore concentrazione rispetto al vino precedente, con il legno che si fa ancora sentire, ma anche con un portamento più elegante delineato da note floreali.
– VOSNE-ROMANEE LES SUCHOTS 1ER 2021, R.
Qui il corredo aromatico vira sulla frutta rossa matura. Il sorso è vellutato, con un tannino che si è già integrato nella massa e che rimanda all’uva e non alla sosta in legno. Si può dire sensuale? Ecco.

– NUITS SAINT GEORGES CLOS DES FORETS SAINT GEORGES 1ER 2021, R.
Sensazioni che mi ricordano il Clos du Chapeau, con l’acidità a dare il ritmo della bevuta. Qui si aggiunge una speziatura marcata. Sono i due vini che mi sembrano più in ritardo nell’integrazione delle componenti. Fatico a farmene un’opinione precisa, ne riconosco la potenzialità intrinseca.

– ROMANEE SAINT-VIVANT GC 2021, R.
Rosa, arancia, fragola di bosco. Profumi dichiarati, senza clamore ma percepibili con precisione. Lieve timbro del legno che non intacca la complessiva armonia. Finale sapido. Gran bel vino.

DOMAINE PERROT-MINOT
Christophe Perrot-Minot è un bell’uomo sui cinquanta, alto, in forma, con occhiali [astigmatico?] e fluenti capelli bianchi screziati di biondo. Ci porta nella sala degustazione sotterranea. Un lungo tavolo di legno, il soffitto ricoperto con le assi delle barrique, tante bottiglie negli scaffali sulle pareti. Ha una “visione intellettuale” del suo lavoro di vignaiolo e dimostra una attenzione profonda al terroir. La dichiara a parole e la conferma con i vini. Ci parla dell’annata 2021, secondo lui più fragile della precedente perché meno equilibrata. Ci sono meno polifenoli nell’uva a proteggere i mosti dall’ossigeno. Saranno perciò vini più diretti ma delicati ed è stata necessaria molta attenzione in vinificazione. Ci racconta dell’annata 2020, calda e siccitosa. C’era il rischio di ottenere vini troppo concentrati e pesanti. Ottenere un’estrazione equilibrata ha comportato un gran lavoro prima nella selezione delle uve e poi in vinificazione. I mosti venivano assaggiati di continuo anche durante i numerosi batonnage. “Bevendo i 2020, così pieni e riccamente estratti, provate a immaginare i 2021, che sono il loro opposto”.

La modalità di vendemmia è totalmente manuale e prevede l’eliminazione in vigna dei soli marciumi, per non contaminare le ceste con le muffe. La selezione vera e propria viene effettuata in cantina sui tavoli di cernita personalmente da Christophe. Il 50% delle uve è vinificato a grappolo intero e per l’invecchiamento si fa ricorso a legni nuovi per circa il 20% dei vini. Dopo la malolattica non si fanno più travasi.
I prezzi sono alti, la rispondenza alle denominazioni è precisa, la qualità è altissima. Christophe ci parla delle basse rese, di importanti quantitativi di uva scartati ogni anno. E se si buttasse via meno uva? Si potrebbero produrre più bottiglie vendendole a prezzi più accessibili. No, l’obiettivo è fare vini buoni, al massimo possibile, vini che devono durare [e cambiare] nel tempo. Vini che devono piacere, prima di tutto, a Christophe stesso.
– MOREY SAINT DENIS LA RUE DE VERGY 2020, R
Al naso ancora non del tutto espressivo, un po’ ritroso. Fresco, snello al sorso e di intensa mineralità.
– GEVREY-CHAMBERTIN JUSTICE DES SEUVREES 2020, R
Più aperto del precedente, più immediato, anche più intenso. I primi due vini sono village molto buoni e già molto godibili.
– CHAMBOLLE-MUSIGNY ORVEAUX DES BUSSIERES VV 2020, R
Unisce la mineralità e la finezza del MSD alla forza delllo GC. Un village che si comporta da premier cru. Non che i primi due vini siano stati tanto da meno.
– MOREY SAINT DENIS LA RIOTTE VV 1ER 2020, R
Profumi intensi e penetranti, tannino presente e maturo. Si caratterizza per un’elegante spina dorsale acida che lo sostiene e ne definisce la direzione.
– CHARMES-CHAMBERTIN GC 2020, R
Minerale, leggiadro, appena segnato dal legno. Da attendere.
– MAZOYERES-CHAMBERTIN GC 2020, R
Ritrovo tutte le caratteristiche che più mi sono piaciute, singolarmente, nei vini precedenti, ognuna al suo massimo, nitida. Vino della degustazione e, per me, del viaggio.
– LA RICHEMONE Vignes Centenaires 2016, R
Un cru di Nuits Saint Georges, una vigna piantata nel 1902. Vino muscoloso, ancora contratto nella sua forza, giovanissimo.

Alla cieca nessuno dei 2020 mi farebbe pensare a un’annata calda. Per quanto giovani, sono vini precisi, estratti con cognizione e senza traccia di costruzione [pensiero cretino mentre bevevo: sto sperimentando, naso e palato, l’essenza dell’uva vendemmiata in quel preciso giorno, trasfigurata e resa a me comprensibile. Decisamente cretino, ne convengo], vini di forza e agilità insieme, tanto profondi da farmi uscire da quella cantina rimbambito e pure tanticchia euforico*.
A livello soggettivo c’è la sensazione di essermi imbattuto in qualcosa che in qualche modo stavo aspettando. Mi riferisco ai pinot neri di Borgogna [no varietale: il varietale diventa assolutamente secondario]. La stessa sensazione provata quando ascoltai per la prima volta Ok Computer dei Radiohead. Era la musica che mi mancava da tutta la vita senza che ne fossi conscio e finalmente qualcuno l’aveva scritta e suonata.
A un livello meno personale, di Perrot-Minot mi colpisce la fedeltà nell’interpretazione delle diverse denominazioni [per quanto possa capirne io che son novizio], ma con uno stile riconoscibile e personale che le tiene tutte saldamente insieme. Intanto che scavo nella memoria per cercare una degustazione di rossi giovani di questo livello complessivo, avverto me stesso: una degustazione in cantina non è la verità. I vini vanno aspettati, seguiti nel tempo, riassaggiati, ragionati. E tuttavia.

*[Qualche giorno fa ho letto su FB un post di un contatto che non conosco di persona ma che leggo spesso (scrive molto bene). Raccontava di una orizzontale dei vini del domaine, annata 2019. Mi ha confortato il riscontro: le osservazioni fatte da lui mi sembrano descrivere la stessa mano dell’ homo faber che ho sentito io. Nelle descrizioni ho qui omesso un aggettivo (carnale) che stava nei miei appunti perché lo avevo ritrovato in quel post. Ovvio, il conforto mi dice solo che per una volta potrei averci capito qualcosa].
DOMAINE PONSOT
La visita alla barricaia con gli assaggi dalle botti lascia qualche dubbio sull’evoluzione futura dei 2021 del Domaine, facendo pensare a quella fragilità di cui si diceva prima. Ma, si sa, le cose cambiano anche piuttosto in fretta tra la botte e la bottiglia.

– CHAPELLE CHAMBERTIN GC 2017, R
Arancia, lampone, fragola. Un’annata classica da queste parti e il vino lo conferma, in equilibrio tra verticalità e polpa. Molto buono.
– GRIOTTE CHAMBERTIN GC 2014, R
Profuma di rosa. Più verticale e meno potente del precedente, sposa tannicità e freschezza sapida.
– CLOS DE LA ROCHE GC VV 2018, R
Caldo sia nei profumi che in bocca. Ha buona freschezza ma tannino ancora invadente e forse qualche nota vegetale di troppo.
– CLOS DE LA ROCHE GC VV 2007, R
Naso elegante, proprio bello. Bocca lievemente fuori fuoco causa acidità ma tenuta comunque in adeguata riga da un tannino maturo. Mi è piaciuto.
– GRIOTTE CHAMBERTIN GC 2006, R
Anche qui l’integrazione dell’acidità nella massa non sembra perfetta. Un’acidità indomita, che salta fuori all’improvviso e che mi pare una costante in molti vini del Domaine. Sembra figlia di quella che percepivo negli assaggi da botte, lì però molto più evidente [e graziarca’]. Non lo chiamerei difetto, sembra invece quasi un marchio di fabbrica, di stile: la scalpitanza.
– MOREY ST. DENIS CLOS DES MONTS LUISANTS 1ER VV 2018, B
Unico 1er cru di Borgogna con uve aligotè e tra i rari bianchi in Cote de Nuits. Agrumato, mieloso e minerale, ha materia e freschezza e al di là di qualche perdonabile sbandamento gustativo si beve con voluttà.

PETIT ROY
Piccolo produttore naturale, assaggi veloci in piedi in una cantina minuscola. Nessun appunto preso, resta un ricordo di vini anche buoni, con qualche immancabile difetto, non trascendentali. Non metto foto perché attaccata al vignaiolo/padre a mò di cozza c’era sua figlia, una bambina, e non pubblico foto di bambini.
Il vino che mi è piaciuto di più è un’anomalia [in senso buono]: uve altesse dalla Savoia che lui vinifica in Borgogna. Ohibò.
CONFURON-COTETIDOT
Ci sono persone che ti piacciono dal primo incontro. E ci sono situazioni che ti colpiscono, inattese e impreviste e che a raccontarle è facile essere banali e pure noiosi. Per cui non vi racconterò di come una cantina caotica, polverosa e buia possa contenere la luce del bello [“Ma è di un bello, il brutto!”], né di quanto possa essere buono[issimo] uno spezzatino di montone con patate, e ho esagerato, lo so da me.

Gli assaggi da botte della 2021 confermano l’idea di una annata scalpitante per i rossi [almeno qui, almeno in questo momento dell’affinamento. Ho detto scalpitante: fragile no, per nulla], i vini bevuti a tavola parlano invece di invecchiamenti felici.


A tavola, poi, non si prendono appunti. Al massimo si scatta qualche fotografia.


MICHEL BOUZEREAU ET FILS
Una dozzina di ettari di proprietà tra Meursault e Puligny, quasi tutti piantati con uve bianche. Tutti i vini fanno affinamento in legno, in barrique di vario passaggio, e vanno in bottiglia a inizio del secondo anno dalla vendemmia. Assaggiamo i campioni dell’annata 2021, pochissimo produttiva causa gelate: ci sarà circa il 30% delle bottiglie rispetto al solito. Non oso immaginare cosa succederà ai prezzi. Se mi limito a questo produttore l’impressione è che per i bianchi la 2021 possa essere annata molto felice. Filo conduttore di tutti i vini è una espressiva mineralità. Jean-Baptiste Bouzereau è un bianchista che si cimenta anche nei rossi con risultati eccellenti. È difficile che un bravo rossista sia ugualmente bravo nel fare vini bianchi, mentre è più frequente incontrare bianchisti che riversano la loro sensibilità in rossi luminosi.

– BOURGOGNE 2021, B
Appelation regionale di qualità decisamente alta. Mineralità e precisione.
– BOURGOGNE CLOS DU MOULIN 2021, B
Ancora più definito del precedente, maggiore l’eleganza, bene integrata la mineralità.
– MEURSAULT LES GRANDS CHARRONS 2021, B
Si sale di livello, con un classico della denominazione, più complesso dei precedenti, dinamico e agrumato.
– MEURSAULT LE LIMOZIN 2021, B
Finora quello con più ciccia. Il legno si sente ancora, restano i marchi di fabbrica di Bouzereau: mineralità e definizione. Finale salato e piccante.
– MEURSAULT LE TESSON 2021, B
Alle solite caratteristiche, che non ripeto, si aggiunge una notevole finezza di trama. In bocca scivola felicemente, non senza frizione, ma è una frizione lieve e rigenerante. È un village ma, mi dice Camillo, è considerato molto di più. A ragione.
– PULIGNY-MONTRACHET LES CHAMPS GAINS 1ER 2021, B
Si avvertono meglio le note grasse dello chardonnay, che non ne frenano tuttavia l’agile movimento al sorso.
– MEURSAULT CHARMES 1ER 2021, B
Charmes è il più grande vigneto premier cru di Mersault. La parte superiore, da cui deriva questo vino, è su terreno calcareo. Ed è il calcare che tiene a bada la grassezza, la misura con la mineralità, conferisce eleganza e porta a concludere con un equilibrato finale ricco di sale. Gran bel vino.

– MEURSAULT LES GENEVRIERES 1ER 2021, B
Il meno immediato della batteria è probabilmente anche il migliore. Comunque è quello che ho preferito, più sussurrato nei profumi, più complesso nelle sue sfaccettature. Una lampadina che si accende piano piano.

– MEURSAULT PERRIERES 1ER 2021, B
Materico, ancora un po’ ingessato, poco concessivo. Ma che gli vuoi dire? Sembra contenere tutto quanto si può desiderare. Lo metti in cantina, aspetti e taci.
– PULIGNY-MONTRACHET LE CAILLERET 1ER 2021, B
Di nuovo grassezza, ma che non frena l’eleganza e con bocca dinamica, slanciata.
– BOURGOGNE 2021, R
I rossi sono in bottiglia da metà dicembre. Delicato nei profumi e al sorso, un vino compiuto.
– POMMARD LES CRAS 2021, R
Potente come ci si aspetta da Pommard, ma anche molto fine.
– VOLNAY LES AUSSY 1ER 2021, R
E questo invece è il Volnay di cui si legge: gentile, con l’eleganza del pinot nero. Profumi netti di fragola e antranilato di metile.
– BEAUNE LES VIGNES FRANCHES 1ER 2021, R
Naso con note terragne, di cioccolato al latte e altre indecifrabili [parlo della mia calligrafia: non capisco cosa ho scritto]. Però molto buono davvero.

6.
Tra gli altri vini bevuti in questi pochi giorni, con un paio di intrusi: un appagante Bourgogne Chardonnay 2020 di Francois Mikulski [a Beaune un locale fichissimo, stancati dal viaggio, svaccati su un divano di fronte al camino], un buonissimo Champagne Roses de Jeanne Cote de Val Vilaine sboccatura 2013, Les Retraits 2017 di Jerome Galeyrand [Cote de Nuits Village che se ne frega della gerarchia delle denominazioni e pure in annata felice], Domaine de Trevallon Les Baux 1990 [vino mitico provenzale che non avevo mai assaggiato. Trattato malissimo dagli incoscienti gestori del locale che lo aveva in carta e filtrato a dovere da Alessandro, subito mi ha lasciato perplesso. Chiuso al naso, con la bocca svogliata più che stanca, leggermente polverosa al centro. Con lentezza si è aperto un po’, poi un altro po’, quindi ancora. All’ultimo sorso ho intravisto quello che subito non avevo capito: sono proprio lento], un Bourgogne Blanc 2017 di Roulot [Bourgogne è la denominazione regionale. Da noi c’è la DOC Piemonte, in Borgogna può capitare che sia Roulot] e persino un felice Erbaluce Le Chiusure 2013 di Favaro.

E poi siamo tornati. Al mattino colazione e via, con un misto di malinconia e gratitudine che è la norma in questi casi.
La mia saggia nonna, che non cessa di guidarmi, diceva: se non si va non si vede. Leggendo di cose di Borgogna mi sentivo distante, né coinvolto né affascinato. Curioso sì, quello sempre.
Qui si viene per il vino e si trova altro, molto altro. Andare in Borgogna, sia pure per pochi giorni, mi ha fatto vedere quello che non riuscivo a immaginare. Un’idea diversa di vino e di luoghi e anche un’idea diversa di me stesso. Se dopo settimane continuo a macinare pensieri è perché qualcosa è scattato [cambiato]. Sì, ci sono luoghi che mi piacciono da subito. E così anche certe persone.

“[i viaggi] migliori non sono quelli più pieni ma quelli che ti lasciano qualcosa, anche con le pause necessarie per fare ordine tra i pensieri. Quelli che ti cambiano dandoti il tempo di capirlo.”
P.C.
7.
“Poiché non sappiamo quando moriremo si è portati a credere che la vita sia un pozzo inesauribile, però tutto accade solo un certo numero di volte, un numero minimo di volte. Quante volte vi ricorderete di un certo pomeriggio della vostra infanzia, un pomeriggio che è così profondamente parte di voi che senza neanche riuscireste a concepire la vostra vita? Forse altre quattro o cinque volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderete levarsi la luna? Forse venti. Eppure tutto sembra senza limite.”
P.B.

[Pensieri seminati tra il 2 e il 5 febbraio 2023 e successivamente germogliati. Se non gela magari fioriscono. A chi c’era durante la semina dico: grazie]
[Sì, ma adesso cosa bevo?]